"Tipote anthropo, tipote lòghia, Nessun uomo, nessuna parola"
Lingua e poesia di un'antica cultura da salvare
Il greco di Calabria che ancora oggi resiste sull'Aspromonte
Meridionale è stato, potremmo dire nell'ultimo millennio, una lingua
essenzialmente orale. Sicuramente un uso circoscritto al mondo subalterno contadino
e pastorale ne ha limitato la versatilità ed il vocabolario. Dalla caduta
del Tema tis Calavrias al XX secolo non si può, verosimilmente,
affermare che sia esistita una tradizione storica scritta del greco di Calabria
a parte alcune rilevanti ma isolate eccezioni come quella di Antonio De Marco
del 1600, "scoperta" in tempi recenti dal prof Mosino. Fra il XIX ed il XX secolo
la lingua ha ripreso ad essere anche tra/scritta ma utilizzando caratteri latini
data la collocazione della minoranza in area italiana. Tutti questi sono problemi
naturalmente da categorie sociali alfabetizzate e che l'area rurale ellenofona,
di cultura orale, non si è posta per secoli. Certo, il riaccendersi in
tempi recenti, di rapporti culturali con la madrepatria linguistica se da una
parte ha incoraggiato la resistenza dei greci di Calabria dall'altra ha in ogni
caso posto il problema della comunicazione e, conseguentemente, dell'alfabeto.
Di fronte ad una lingua fortemente in crisi si pongono
alcuni importanti problemi di scenario anche in virtù della recentissima
(e forse un po' tardiva) legge di tutela delle minoranze linguistiche italiane.
Si riuscirà ad insegnare il greco di Calabria
nelle scuole? Ed accanto ad esso bisognerà insegnare anche il greco moderno
per dare una prospettiva più ampia alle antiche radici? Sono due domande
fondamentali e di difficile risposta ma che contengono alcune delle prospettive
di salvezza per la lingua. Tutte le altre riguardano il mondo economico. Senza
alcuna prospettiva di sviluppo sostenibile per le aree interne esse saranno
oggetto di definitivo svuotamento: tipote anthropo, tipote lòghia
(nessun uomo, nessuna parola).
Dalla poesìa contadina ad una
nuova voce ellenofona
Un mondo contadino e pastorale legato ad una cultura
trasmessa oralmente non ha potuto lasciare molte testimonianze scritte. Essenzialmente
le voci ellenofone sono state più trascritte che scritte. Come il caso
dei folcloristi italiani "a caccia" di canti popolari anche fra i greci di Calabria
nel XIX secolo. Nel XX secolo, la diffusione dell'alfabetizzazione ha fatto
sì che alcuni poeti del mondo contadino abbiano in qualche modo potuto
lasciare una traccia della loro voce. Senza dubbio si tratta di testi inconfondibilmente
legati ad una matrice "orale", a ciò che anche in area ellenofona si
definiva il puesiare ciò il creare estemporaneamente, a braccio
forme poetiche secondo i canoni tradizionali. Questa traccia pastorale e contadina
si legge grossomodo nelle voci più importanti della poesia tradizionale
grecanica: Bruno Casile, Mastr'Angelo Maesano, gli stessi fratelli Siviglia.
Diverso il caso di Salvino Nucera. Per quanto anch'egli
provenga da un mondo profondamente popolare si tratta di un autore che ha avuto
l'opportunità di compiere studi letterari e di eleborare un proprio percorso
in un ambito direttamente "scritto". Di natura senz'altro letteraria, a tratti
intellettuale (nel senso migliore del termine) è l'esperienza di questo
scrittore che rappresenta oggi, fuori dal panorama del puesiare contadino,
la voce più alta della scrittura in grecanico.
Poeti greco-calabri del '900
 Bruno
Casile (Bova 1923 - 1998)
Bruno
Casile (Bova 1923 - 1998)
Bruno Casile deve parte della sua notorietà
alla "scoperta" della sua poesia "contadina" ad opera di Pasolini. Era un uomo
schivo tanto da parere scontroso. In realtà la sua riservatezza montanara
legata ad un modo viscerale di vivere i luoghi e la terra di appartenenza si
trovano alla radice delle sua esperienza di poeta popolare. Nei versi che seguono
l'esaltazione sentimentale di un semplice cosmo rurale profondamente amato bene
riflettono la figura di Casile.
| I manamu mu gapai mu gapai, mu gapai jatì an da pediati egò imme i protinì O ciùrimu mu gapai, mu gapai, mu gapai jatì egò sto spiti canno panda ticandì O pappùmmu mu gapai mu gapai, mu gapai jatì tu ferro panda mmia llampa zze crasì I pudda mu gapai mu gapai, mu gapai, jatì catha mera egò ti ddonno to faghì I scidda mu gapai mu gapai, mu gapai jatì otu o cosmo tis tin ècame ti zzichì I gadara mu gapai, mu gapai, mu gapai, jatì ti donno ja na fai catha mera pleo poddì. |
Mia mamma mi ama mi ama, mi ama perché dei suoi bambi io sono la più grande Mio padre mi ama mi ama, mi ama perché in casa faccio sempre qualcosa Mio nonno mi ama mi ama, mi ama perché gli porto sempre un bicchiere di vino La gallina mi ama mi ama, mi ama perché ogni giorno le do da mangiare La cagna mi ama mi ama, mi ama perché così il mondo ha creato il suo animo L'asina mi ama, mi ama, mi ama perché le do da mangiare ogni giorno di più. |
 Mastr'Angelo
Maesano (Roghudi Vecchio 1915 - Roghudi Nuovo 2000)
Mastr'Angelo
Maesano (Roghudi Vecchio 1915 - Roghudi Nuovo 2000)
Splendido, carismatico personaggio di emblematica
saggezza antica, Mastr'Angelo Maesano ha saputo spesso coniugare la limpida
semplicità dei suoi versi ad un vissuto tante volte drammatico legato
all'esperienza della guerra e del campo di concentramento ed alle sorti del
suo paese, Roghùdi. Il soprannome di Mastro che lo ha accompagnato tutta
la vita si deve alla professione artigiana di muratore. Musicista e raffinato
cantante della tradizionale traguda sulla ciramedda, Mastr'Angelo
è rimasto sino all'ultimo un mite ma deciso testimone della grecità
calabrese.
| Calabria dìkimu ti ìsso addimonimèni andi Europa ìsso cipùri athìsse mia forà kàtha domàdi ciòla to chùma èkanne addùri ma i àthropi ti èchome sti Roma se afìkai na pethànnise àsce pìna Ecìtte apàno kanè se canunài iatì èchusi iomàti ti cilìa. Ciuma pos ène ènan àthropo palèo ti èrkete kanè ti se asciunnài An èchise pìna sire tin currìa ti èrkete i òra ti o ìlgio èchi na pettòi Pis èkame zimìa èchi na clèi iatì ciòla o Christò mas afudài |
Calabria mia che sei dimenticata d'Europa eri il giardino fiorivi una volta a settimana anche la terra profumava ma quelli che abbiamo a Roma ti hanno lasciata morire di fame Di là sopra nessuno ti guarda che hanno già la pancia piena dormi come fa un vecchio perché nessuno verrà a svegliarti Se avrai fame stringi la cinghia che arriva l'ora quando il sole dovrà levarsi chi avrà fatto danni dovrà piangere perché anche Cristo ci aiuterà. |
Agostino Siviglia (Chorìo
di Roghudi 1934)
Simile al fratello Carmelo, anch'egli poeta popolare,
nell'orgogliosa difesa della cultura d'appartenenza, Agostino Siviglia rappresenta
una sincera voce di nostalgia per un cosmo arcaico infranto dalla "deportazione"
degli abitanti di Roghudi e di Chorìo nel nuovo sito nei pressi di Melito.
| Ghorìo dicòmmu pos eienàstise palèo glossa dichìmu plèo den tragudào Thorò to spìti ti einasti palèo ciòla t'ambeli ti eienàsti ghierondàro. Condoferro apìsso ce clònda pào jatì tin màna den eho plèo. Ce essà filisa, paracalò mi fighite appòde ando horìo Mathete tin glossa ton pedìo jatì imme palèo ce egò pào. |
Paese mio come ti sei fatto vecchio lingua mia più non canto Vedo la casa ch'è diventata vecchia la vigna pure che s'è appassita Ritorno indietro e vado piangendo perché la mamma non ho più E voi amici, per favore non fuggite il mio paese Insegnate la lingua ai bambini ch'io sono vecchio e passato oramai |
|
|
|
|
Cosa leggere sulla lingua greca di Calabria:
- A. Karanastasis, Istoricòn lexicòn ton
ellenicòn idiomàton tis catoitalias, 5 vols, 1984-1992
- G. Rohlfs, Lexicon Graecanicum Italiae Inferioris,
Tubingen, 1964
- G. Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico
della Calabria, Ravenna, 1974.
- E.Brighenti, Dizionario Greco Moderno Italiano,
Milano, 1927.
- G. Rossi-Taibbi, G. Caracausi, Testi Neogreci
di Calabria, Palermo , 1959
- B. Spano Grecità bizantina (…), Pisa
, 1960
- R. Browning, Medieval and Modern Greek, Hutchinson
and Co. (Publishers) Ltd, London, Great Britain, 1969.
- G. A. Crupi, La glossa di Bova, Roma, 1980
- N. Andriotis, Etimologhicò lexicò
tis kinìs neoellenikis, Thessaloniki, 1983
- F. Mosino, Storia Linguistica della Calabria,
Cosenza, 1987
- F. Condemi, Grammatica Grecanica, Reggio
C.,1987
- D. Minuto, La quercia greca, Reggio C. 1974
- D. Minuto, S. Nucera, M. Zavattieri, Dialoghi
Greci di Calabria, Reggio Calabria, 1988
- Tegopoulos Fytrakis, Ellenico Lexico, Athena,
1993
- N. Kontosopoulos, Dialectoi kai Idiomata tis
Neas Ellenikis, Athens, 1994
- A. Casile, D. Fiorenza, Ellenofoni di Calabria,
Bova M., 1994
- F. Mosino, Dal greco antico al greco moderno,
Reggio Calabria, 1995
- M. Katsoyannou, Le parler grico de Galliciano
(Italie): description d'une langue en voie de disparition, These de Doctorat,
Paris VII, 1995.
- F. Montanari, Vocabolario della lingua greca,
Torino, 1995
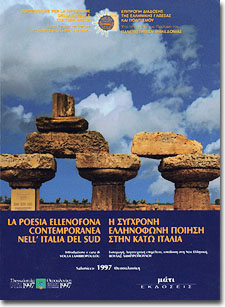 -
Council of Europe, Report: A Programme of Case Studies Concerning the Inclusion
of Minorities as Factors of Cultural Policy and Action, Council for Cultural
Co-opration (CDCC), Strasbourg, 1996
-
Council of Europe, Report: A Programme of Case Studies Concerning the Inclusion
of Minorities as Factors of Cultural Policy and Action, Council for Cultural
Co-opration (CDCC), Strasbourg, 1996
- F. Violi, Lessico
grecanico-italiano-grecanico, Bova, 2001
Cosa leggere sulla poesia e letteratura greca di Calabria:
Oltre alle opere edite dei singoli autori citati, per una "visione d'insieme", l'unica iniziativa antologica di un certo rilievo sulla poesia greco-calabra è:
La poesìa ellenofona contemporanea nell'Italia del Sud, a cura di Voula Lambropoulou, Salonicco, 1997.
Segnaliamo inoltre:
F. Violi, Storia della Letteratura grecanica, Reggio Calabria, 2000
In Internet:
A cura di Sara Minuto, molto interessante anche per gli esempi sonori il sito dell'Università di Patrasso, Graecanic Lexicon sugli ellenofoni di Calabria e di Puglia: www.wcl2.ee.upatras.gr/Project/Grec/index.html