|
CULTURA ORALE, MA ANCHE GRANDI LETTERATI E PATRIOTI...
La cultura arbëreshe è orale e preletterata e si basa su una lingua esclusivamente parlata e non scritta, e su manifestazioni, atteggiamenti e comportamenti tipici trasmessi per via orale. Gli albanesi sono una popolazione bilingue: l'italiano rappresenta per loro la lingua dell'ufficialità e l'arbëresh, la lingua della famiglia, che ha per la comunità una sorta di funzione aggregativa. La "gitonia" (il vicinato), la "mikpritia" (l'ospitalità), e la "besa", la parola data, rappresentano alcuni degli elementi più originali e tradizionali della cultura popolare arbëreshe. Sono maggiormente sopravvissuti i riti legati al fattore religioso e le Vallje (ridde), in ricordo di Skanderbeg che nei giorni successivi la Pasqua, la gente rievoca con canti e danze. Questa tradizione è ancora molto viva a Civita, Frascineto, Acquaformosa, Cervicati e Mongrassano. Caratteristica è anche la commemorazione dei defunti: la gente si reca nei cimiteri e ricerca l'unità spezzata dalla morte. Qualche aspetto del passato è possibile coglierlo nella cerimonia del rito nuziale e nel costume, simbolo dell'etnia e capolavoro di artigianato. La religione e la lingua sono i due elementi caratterizzanti della cultura albanofona, l'albanese assieme al greco bizantino rappresenta la infatti la lingua ufficiale della liturgia arbëreshe di rito bizantino. |
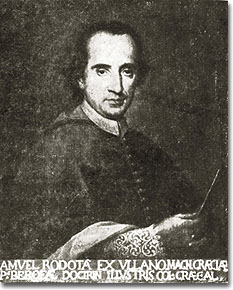 Il
merito di aver propagato la cultura tra gli albanesi d'Italia va dato
alla illustre e benemerita famiglia Rodotà de' Coronei di San
Benedetto Ullano. Il sacerdote D.Stefano Rodotà, aveva
compreso che il miglior modo di istruire i suoi connazionali sarebbe stato
la creazione di un Collegio in Calabria con a capo un Vescovo di rito
greco. Felice Samuele Rodotà, fratello del precedente e
compagno di studi di Papa Clemente XII, ottenne ampie e formali assicurazioni
in proposito. E l'11 ottobre 1732 veniva fuori la prima Bolla di fondazione
del Collegio. che, in onore all'illustre fondatore, veniva denominato:
"Collegio Italo-Albanese Corsini". Il Rodotà, nella sua qualità
di Arcivescovo, otteneva la facoltà di conferire lauree dottorali
in Filosofia Teologica. Il Collegio assunse in seguito, fama di uno dei
migliori del reame delle Due Sicilie, sì da attirare l'attenzione
di Ferdinando IV, Giacchino Murat e Giuseppe Garibaldi. Nel marzo del
1794, il collegio veniva traslocato a San
Demetrio Corone col pretesto che le condizioni climatiche in San
Benedetto fossero poco propizie alla salute degli alunni. E' in questo
Collegio che hanno studiato e si sono formati gli uomini più illustri
italo-albanesi. Ricorderemo fra gli altri: Giulio Variboba, autore delle
Laudi e della vita di Maria Santissima; Francesco Antonio Santori; Giuseppe
Serembe. Ma il più grande poeta fu Gerolamo De Rada che si prodigò
per divulgare le memorie del disperso sangue albanese. Pubblicò
il "Milosao"; nel 1883 fonda il periodico "Fjamuri i Arberit". Il
merito di aver propagato la cultura tra gli albanesi d'Italia va dato
alla illustre e benemerita famiglia Rodotà de' Coronei di San
Benedetto Ullano. Il sacerdote D.Stefano Rodotà, aveva
compreso che il miglior modo di istruire i suoi connazionali sarebbe stato
la creazione di un Collegio in Calabria con a capo un Vescovo di rito
greco. Felice Samuele Rodotà, fratello del precedente e
compagno di studi di Papa Clemente XII, ottenne ampie e formali assicurazioni
in proposito. E l'11 ottobre 1732 veniva fuori la prima Bolla di fondazione
del Collegio. che, in onore all'illustre fondatore, veniva denominato:
"Collegio Italo-Albanese Corsini". Il Rodotà, nella sua qualità
di Arcivescovo, otteneva la facoltà di conferire lauree dottorali
in Filosofia Teologica. Il Collegio assunse in seguito, fama di uno dei
migliori del reame delle Due Sicilie, sì da attirare l'attenzione
di Ferdinando IV, Giacchino Murat e Giuseppe Garibaldi. Nel marzo del
1794, il collegio veniva traslocato a San
Demetrio Corone col pretesto che le condizioni climatiche in San
Benedetto fossero poco propizie alla salute degli alunni. E' in questo
Collegio che hanno studiato e si sono formati gli uomini più illustri
italo-albanesi. Ricorderemo fra gli altri: Giulio Variboba, autore delle
Laudi e della vita di Maria Santissima; Francesco Antonio Santori; Giuseppe
Serembe. Ma il più grande poeta fu Gerolamo De Rada che si prodigò
per divulgare le memorie del disperso sangue albanese. Pubblicò
il "Milosao"; nel 1883 fonda il periodico "Fjamuri i Arberit". |
 A
questi luminari della letteratura albanese seguono ancora: D.Vincenzo
Stratigò da Lungro; Pasquale
Baffi da S.Sofia d'Epiro, martire
della Repubblica Napoletana, eminente filosofo; Domenico Mauro da S.Demetrio
Corone, cospiratore e letterato insigne, patriota e capo del movimento
insurrezionale calabrese, deputato al Parlamento Italiano; Pasquale Scura
da Vaccarizzo Albanese, patriota
fervido, fu ministro di Grazia e Giustizia con Garibaldi nel 1860; Francesco
Crispi, avvocato e statista di grande fama, fu due volte Presidente del
Consiglio dei Ministri. A queste figure di letterati è necessario
metterne in risalto le più rappresentative del Risorgimento Italiano:
Domenico Dramis, cospiratore ardito che partecipò ai moti del 1844;
Giovanni Mosciaro, carbonaro fervente; Agesilao Milano che tentò
di uccidere nel 1856 il re Ferdinando Il durante una parata militare.
Nonostante anni di discriminazioni culturali le comunità arbëreshë
sono riuscite a sopravvivere conservando molte delle loro tradizioni e
dei loro riti, e negli ultimi tempi, sono state al centro di un complesso
processo di risveglio culturale non più circoscritto ad un cerchio
ristretto di intellettuali, in particolar modo ai papàs (i preti
di rito greco), che nei secoli hanno salvaguardato la tradizione della
identità linguistica e culturale italo-albanese. A
questi luminari della letteratura albanese seguono ancora: D.Vincenzo
Stratigò da Lungro; Pasquale
Baffi da S.Sofia d'Epiro, martire
della Repubblica Napoletana, eminente filosofo; Domenico Mauro da S.Demetrio
Corone, cospiratore e letterato insigne, patriota e capo del movimento
insurrezionale calabrese, deputato al Parlamento Italiano; Pasquale Scura
da Vaccarizzo Albanese, patriota
fervido, fu ministro di Grazia e Giustizia con Garibaldi nel 1860; Francesco
Crispi, avvocato e statista di grande fama, fu due volte Presidente del
Consiglio dei Ministri. A queste figure di letterati è necessario
metterne in risalto le più rappresentative del Risorgimento Italiano:
Domenico Dramis, cospiratore ardito che partecipò ai moti del 1844;
Giovanni Mosciaro, carbonaro fervente; Agesilao Milano che tentò
di uccidere nel 1856 il re Ferdinando Il durante una parata militare.
Nonostante anni di discriminazioni culturali le comunità arbëreshë
sono riuscite a sopravvivere conservando molte delle loro tradizioni e
dei loro riti, e negli ultimi tempi, sono state al centro di un complesso
processo di risveglio culturale non più circoscritto ad un cerchio
ristretto di intellettuali, in particolar modo ai papàs (i preti
di rito greco), che nei secoli hanno salvaguardato la tradizione della
identità linguistica e culturale italo-albanese. |
